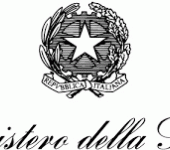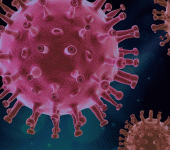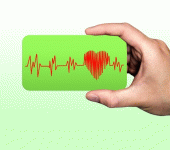Il trapianto di midollo da donatore è una delle terapie più efficaci per curare la leucemia mieloide acuta (AML), grazie all’attività antitumorale del sistema immunitario che viene trasferito dal donatore al paziente.
A volte però sopraggiunge la recidiva. Le cellule leucemiche riescono a sottrarsi al sistema immunitario. In questo caso, servono altri sistemi per fare in modo che le nostre difese possano agire contro il cancro. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano che ha studiato questo processo analizzando le cellule tumorali e i linfociti T che cercano di sconfiggerle, prima e dopo la terapia. Nel lavoro, condotto grazie al sostegno di Airc e pubblicato in due articoli su Nature Medicine e Nature Communications, attraverso analisi genetiche e di espressione genica, i ricercatori hanno svelato le strategie di sopravvivenza che il tumore mette in atto sotto la pressione immunologica del trapianto.
Già nel 2009, gli stessi ricercatori che oggi firmano i due articoli avevano trovato una parte della risposta. A volte a salvare le cellule leucemiche è una mutazione genetica nel DNA, che cambia le molecole HLA presenti sulla loro superficie e le rende più simili (e quindi invisibili) alle cellule del sistema immunitario trapiantato. Una scoperta che ha già influenzato la pratica clinica: quando ciò accade i medici sanno che si deve ricorrere a un secondo trapianto di midollo, da un donatore diverso dal primo. Questa modifica genetica non spiega però tutte le recidive che si osservano.
Nei nuovi studi oggi pubblicati i ricercatori del San Raffaele dimostrano che ci sono altre due soluzioni – questa volte epigenetiche, non genetiche – trovate dalle cellule del tumore per salvarsi: da un lato riducono l’espressione delle molecole HLA sulla superficie, silenziando i loro geni e nascondendosi così al pattugliamento dei linfociti; dall’altro aumentano la presenza di alcuni recettori immunosoppressori che segnalano ai linfociti di frenare la loro attività fino a inattivare la risposta immunitaria.
«Comprendere, caso per caso, quale meccanismo dà origine alla recidiva permetterà di classificare meglio i pazienti e dare loro un trattamento specifico», spiega Luca Vago, medico e capo unità di ricerca. «L’obiettivo è un approccio personalizzato alle recidive, che permetterà di migliorare gli esiti non grazie a nuovi opzioni terapeutiche, ma trovando un nuovo razionale per le terapie già disponibili».
Nel primo caso infatti, in cui le molecole di riconoscimento HLA vengono espresse troppo poco, si può creare uno stato infiammatorio controllato e alzare così il livello di interferone nel sangue, una molecola che sappiamo promuovere l’espressione di queste molecole. Nel secondo caso invece, quando l’attività dei linfociti T è stata spenta dal tumore, si possono somministrare gli inibitori dei checkpoint immunitari, farmaci che sbloccano i freni dei linfociti T e attivano nuovamente la risposta immune. Invertire i trattamenti nei due casi rischia di essere non solo inefficace, ma addirittura controproducente.
Quanto scoperto dai ricercatori apre la strada non solo a un approccio personalizzato alla recidiva, ma anche a nuove prospettive di diagnosi precoce. «L’attivazione dei processi inibitori nei linfociti T, in particolare in quelli “di memoria” che si trovano nel midollo osseo, precedono di molto la ricomparsa del tumore», spiega Chiara Bonini vice direttrice della divisione di ricerca in Immunologia, Trapianti e Malattie Infettive. «Il prelievo di queste cellule dal midollo dei pazienti e la loro analisi potrebbe costituire in futuro una strategia di diagnosi precoce della recidiva».