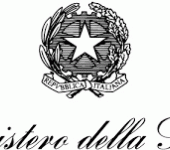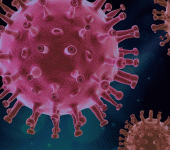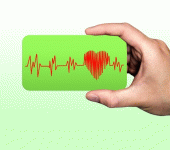Può sembrare un paradosso, ma uno dei maggiori stimoli allo sviluppo della medicina è provenuto dalla guerra. D’altronde, curare la ferita di un soldato non è solo un fatto privato, ma una necessità strategica, sopravvivenziale per l’intero gruppo sociale e solo in un secondo momento tali conquiste possono rivelarsi utili anche per la vita civile. Da qui la necessità di stabilire cure e terapie efficaci, di sperimentarle, praticarle e tramandarle in codici e papiri che in molti casi, per fortuna sono giunti sino a noi.
Per quanto in Mesopotamia e in Egitto l’elemento magico-religioso fosse onnipresente ed essenziale per la cura delle ferite di guerra – cosa che probabilmente deve aver pur sortito una sorta di positivo “effetto placebo” – in diversi casi la scelta di particolari sostanze curative svela una ratio insospettata, frutto dell’esperienza clinica empirica, che anticipa di secoli e millenni le più importanti scoperte della scienza.
Acetato di rame
Ad esempio, il problema della setticemia che falcidiava i militari feriti fu contrastato con l’intuizione di alcune pratiche igieniche e con l’utilizzo di sostanze dotate di un potere antibatterico che sarebbe stato dimostrato solo ai nostri giorni.
Dagli studi di Emily K. Teall risulta che nell’antica Mesopotamia, erano note più di 250 specie vegetali e circa 120 minerali i quali venivano impiegati in cataplasmi agglutinati da miele, grasso, latte, olio in decine di diverse ricette.
La birra veniva utilizzata soprattutto dai Sumeri per pulire le ferite prima di procedere all’applicazione di pomate e fasciature. In effetti, oltre al moderato contenuto di alcol, notoriamente disinfettante, la birra possiede alcune interessanti proprietà detergenti tanto da essere tradizionalmente utilizzata per smacchiare legno e metalli. La sua effervescenza, probabilmente, poteva anche giovare nel rimuovere polvere o corpuscoli che fossero penetrati nella ferita.
A volte, tuttavia, poteva anche far parte integrante delle pomate, come riporta una tavoletta scritta in caratteri cuneiformi 4.200 anni fa: “Mescolare trementina di pino, tamarisco, margherita, farina di grano; aggiungere latte e birra in un piccolo recipiente di rame; spalmare sulla pelle, bendare e lasciar recuperare il paziente”.
Papiro di Edwin Smith
Infine, una pianta che veniva utilizzata già in Mesopotamia e che oggi conosce una grande fortuna era l’aloe, il cui succo denso e gelatinoso possiede confermate proprietà immunostimolanti, antinfiammatorie, cicatrizzanti e antibatteriche.
Gli Egizi, dal canto loro, come illustrato da Richard D. Forrest in un articolo del Journal of the Royal Society of Medicine, erano invece grandi utilizzatori del miele, e non a torto: uno studio condotto nel 2011 dai ricercatori della Sapienza sulle proprietà del prodotto apiario - soprattutto di quello derivante da agrumi, eucalipto e timo - ha svelato la sua potente funzione battericida e quella di inibitore del sistema di comunicazione batterico noto come “quorum sensing” grazie al quale i microbi riescono a implementare la loro attività e presenza.
Strumenti medici egiziani
I risultati sono stati confermati anche da un’altra ricerca di Molan-Rhodes del 2015, “Honey, a biologic wound dressing”: l’acidità del miele aumenta il rilascio di ossigeno dall'emoglobina del sangue rendendo l’ambiente della ferita poco adatto alla proliferazione dei batteri e quindi accelera il processo di guarigione. Oltretutto, facilita il drenaggio dei liquidi prodotti dalla lesione e, sempre grazie all’osmosi, riesce anche a disidratare le cellule batteriche. La sua consistenza impedisce, inoltre, che le fasciature si attacchino al sangue coagulato.
Come risulta dal Papiro di Edwin Smith, di 3.600 anni fa, gli Egizi utilizzavano già delle specie di garze in tessuto vegetale.
Anche il grasso e le resine vegetali svolgevano la stessa funzione lubrificante e, tra l’altro, veniva talvolta utilizzata la resina di incenso che, come abbiamo già visto in un precedente articolo, possiede una notevole carica antibatterica. Inoltre, il forte profumo dell’incenso poteva nascondere eventuali cattivi odori emanati dalla ferita.
Tra le sostanze più rivestite di significati magico-religiosi vi era il “verdigris”, un pigmento verde (il “colore della vita”) ottenuto dall’acetato di rame, un ossido prodotto versando aceto su lastre del metallo rosso. E’ una sostanza tossica per l’organismo, ma anche fortemente disinfettante, così come il mercurio, altro metallo impiegato spesso nella medicina antica.
L’applicazione più strana e impensabile degli Egizi, tuttavia, faceva ricorso a … escrementi d’asino, nella credenza che il fetore potesse allontanare gli spiriti maligni.
Ancor oggi, in alcuni paesi africani, si utilizza lo sterco soprattutto per sigillare la parte finale del cordone ombelicale. In India, invece, quello di vacca fa parte della medicina tradizionale e recentemente è stato riproposto addirittura per la cura del Coronavirus.
Ovviamente, le feci sono un vettore privilegiato per la trasmissione di infezioni, ma secondo alcuni, anche in questo caso, la trovata egizia non era del tutto peregrina: stando ad alcune ricerche, infatti, il “medicamento”, prodotto da un erbivoro provvisto di pancreas come l’asino, contiene un enzima chiamato tripsina che avrebbe potuto favorire il processo di guarigione.
Potendo scegliere, meglio il miele, comunque.
Può sembrare un paradosso, ma uno dei maggiori stimoli allo sviluppo della medicina è provenuto dalla guerra. D’altronde, curare la ferita di un soldato non è solo un fatto privato, ma una necessità strategica, sopravvivenziale per l’intero gruppo sociale e solo in un secondo momento tali conquiste possono rivelarsi utili anche per la vita civile. Da qui la necessità di stabilire cure e terapie efficaci, di sperimentarle, praticarle e tramandarle in codici e papiri che in molti casi, per fortuna sono giunti sino a noi.
Per quanto in Mesopotamia e in Egitto l’elemento magico-religioso fosse onnipresente ed essenziale per la cura delle ferite di guerra – cosa che probabilmente deve aver pur sortito una sorta di positivo “effetto placebo” – in diversi casi la scelta di particolari sostanze curative svela una ratio insospettata, frutto dell’esperienza clinica empirica, che anticipa di secoli e millenni le più importanti scoperte della scienza.
Acetato di rame
Ad esempio, il problema della setticemia che falcidiava i militari feriti fu contrastato con l’intuizione di alcune pratiche igieniche e con l’utilizzo di sostanze dotate di un potere antibatterico che sarebbe stato dimostrato solo ai nostri giorni.
Dagli studi di Emily K. Teall risulta che nell’antica Mesopotamia, erano note più di 250 specie vegetali e circa 120 minerali i quali venivano impiegati in cataplasmi agglutinati da miele, grasso, latte, olio in decine di diverse ricette.
La birra veniva utilizzata soprattutto dai Sumeri per pulire le ferite prima di procedere all’applicazione di pomate e fasciature. In effetti, oltre al moderato contenuto di alcol, notoriamente disinfettante, la birra possiede alcune interessanti proprietà detergenti tanto da essere tradizionalmente utilizzata per smacchiare legno e metalli. La sua effervescenza, probabilmente, poteva anche giovare nel rimuovere polvere o corpuscoli che fossero penetrati nella ferita.
A volte, tuttavia, poteva anche far parte integrante delle pomate, come riporta una tavoletta scritta in caratteri cuneiformi 4.200 anni fa: “Mescolare trementina di pino, tamarisco, margherita, farina di grano; aggiungere latte e birra in un piccolo recipiente di rame; spalmare sulla pelle, bendare e lasciar recuperare il paziente”.
Papiro di Edwin Smith
Infine, una pianta che veniva utilizzata già in Mesopotamia e che oggi conosce una grande fortuna era l’aloe, il cui succo denso e gelatinoso possiede confermate proprietà immunostimolanti, antinfiammatorie, cicatrizzanti e antibatteriche.
Gli Egizi, dal canto loro, come illustrato da Richard D. Forrest in un articolo del Journal of the Royal Society of Medicine, erano invece grandi utilizzatori del miele, e non a torto: uno studio condotto nel 2011 dai ricercatori della Sapienza sulle proprietà del prodotto apiario - soprattutto di quello derivante da agrumi, eucalipto e timo - ha svelato la sua potente funzione battericida e quella di inibitore del sistema di comunicazione batterico noto come “quorum sensing” grazie al quale i microbi riescono a implementare la loro attività e presenza.
Strumenti medici egiziani
I risultati sono stati confermati anche da un’altra ricerca di Molan-Rhodes del 2015, “Honey, a biologic wound dressing”: l’acidità del miele aumenta il rilascio di ossigeno dall'emoglobina del sangue rendendo l’ambiente della ferita poco adatto alla proliferazione dei batteri e quindi accelera il processo di guarigione. Oltretutto, facilita il drenaggio dei liquidi prodotti dalla lesione e, sempre grazie all’osmosi, riesce anche a disidratare le cellule batteriche. La sua consistenza impedisce, inoltre, che le fasciature si attacchino al sangue coagulato.
Come risulta dal Papiro di Edwin Smith, di 3.600 anni fa, gli Egizi utilizzavano già delle specie di garze in tessuto vegetale.
Anche il grasso e le resine vegetali svolgevano la stessa funzione lubrificante e, tra l’altro, veniva talvolta utilizzata la resina di incenso che, come abbiamo già visto in un precedente articolo, possiede una notevole carica antibatterica. Inoltre, il forte profumo dell’incenso poteva nascondere eventuali cattivi odori emanati dalla ferita.
Tra le sostanze più rivestite di significati magico-religiosi vi era il “verdigris”, un pigmento verde (il “colore della vita”) ottenuto dall’acetato di rame, un ossido prodotto versando aceto su lastre del metallo rosso. E’ una sostanza tossica per l’organismo, ma anche fortemente disinfettante, così come il mercurio, altro metallo impiegato spesso nella medicina antica.
L’applicazione più strana e impensabile degli Egizi, tuttavia, faceva ricorso a … escrementi d’asino, nella credenza che il fetore potesse allontanare gli spiriti maligni.
Ancor oggi, in alcuni paesi africani, si utilizza lo sterco soprattutto per sigillare la parte finale del cordone ombelicale. In India, invece, quello di vacca fa parte della medicina tradizionale e recentemente è stato riproposto addirittura per la cura del Coronavirus.
Ovviamente, le feci sono un vettore privilegiato per la trasmissione di infezioni, ma secondo alcuni, anche in questo caso, la trovata egizia non era del tutto peregrina: stando ad alcune ricerche, infatti, il “medicamento”, prodotto da un erbivoro provvisto di pancreas come l’asino, contiene un enzima chiamato tripsina che avrebbe potuto favorire il processo di guarigione.
Potendo scegliere, meglio il miele, comunque.