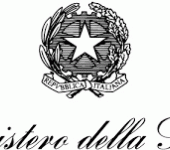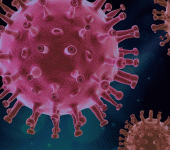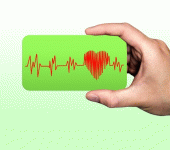Una volta accertata l’esclusiva localizzazione nella ghiandola, oggi sono diverse le opportunità per trattare un tumore della prostata: a partire dalla rimozione chirurgica (prostatectomia radicale) fino ad arrivare alla sorveglianza attiva .
Questa strategia di «attesa» permette di rinunciare in prima battuta all’intervento e di ricorrervi eventualmente in un secondo momento: soltanto nel caso in cui la malattia evidenzi segni di progressione. La seconda scelta - viene consigliata all’incirca in un nuovo paziente su tre - è talora possibile perché alcuni tumori della prostata, al pari di quelli della tiroide , crescono molto lentamente. Motivo per cui, soprattutto ai pazienti più anziani e con altri problemi di salute, viene consigliato di rinunciare all’intervento (spesso non privo di effetti collaterali) e di sottoporsi a un calendario più serrato di controlli. L’opportunità deve però essere fatta presente soltanto nei casi in cui la scelta della sorveglianza attiva non vada a intaccare le probabilità di sopravvivenza. Ma quando si può evitare (o rimandare) l’intervento senza mettere a repentaglio la salute di un uomo?
Gli ultimi dati «premiano» la chirurgia
A riaprire il dibattito è uno studio pubblicato sul «New England Journal of Medicine», che ha osservato per quasi trent’anni - l’arruolamento è iniziato nel 1989 e s’è concluso nel 1999, mentre l’osservazione è durata fino al 2017- il decorso della malattia in 695 pazienti scandinavi: tutti con meno di 75 anni e colpiti da un tumore della prostata non diffusosi oltre la ghiandola, per metà operati e per metà monitorati nel tempo. Il lungo follow-up ha «premiato» la scelta dell’intervento.
Vent’anni dopo la diagnosi, l’80 per cento del totale dei pazienti era deceduto (la quota più alta proveniva dal gruppo dei pazienti non trattati chirurgicamente). Ma tra coloro che erano stati operati, risultava ancora vivo il 24,8 per cento dei pazienti: rispetto al 16,1 per cento misurato nel gruppo di uomini a cui era stata indicata la vigile attesa. E in media la prostatectomia radicale è stata associata a un aumento medio di quasi tre anni della sopravvivenza e a una riduzione del numero di pazienti con malattia metastatica.
«L’asportazione della prostata è associata a un miglioramento della sopravvivenza e a una riduzione del rischio di sviluppare metastasi nei pazienti affetti da un tumore della prostata clinicamente localizzato - afferma Francesco Montorsi, direttore dell’unità operativa di urologia dell’ospedale San Raffaele di Milano -. I pazienti che hanno un tumore della prostata a rischio intermedio o elevato e che hanno una lunga aspettativa di vita hanno una concreta possibilità di guarire con l’intervento chirurgico».
Considerazioni che trovano d’accordo Francesco Porpiglia, alla guida dell’urologia dell’ospedale San Luigi di Orbassano (Torino). «Sapevamo che, nei dieci successivi alla diagnosi, la scelta di un’opzione piuttosto che di un’altra spesso non garantisce vantaggi in termini di sopravvivenza. Ma a distanza di tempo, il divario tra le due curve aumenta a favore dei pazienti che hanno subito un trattamento attivo». Un aspetto che conferma come il tumore della prostata cresca molto lentamente. E che spiega perché, nel confronto a breve termine, spesso non si osservano variazioni nel decorso della malattia, che invece possono comparire spostando più avanti il «traguardo» dell’osservazione. Tradotto: i decessi per tumore della prostata non si sono azzerati, ma possono comparire nel tempo se la scelta del trattamento non è stata adeguata.
La qualità della diagnosi fa la differenza
La difficoltà - per urologi, radiologi e oncologi - sta nell’individuare la strategie di cura più adeguata per ogni paziente. La priorità è rappresentata dal controllo della malattia oncologica, anche se non irrilevante è la richiesta di molti uomini di non vedere compromessa la propria qualità di vita. A spaventarli, spesso, è il rischio di vedere intaccata la propria autonomia (incontinenza) e virilità (deficit erettile) come conseguenza dell’intervento chirurgico. Da qui l’opportunità di ricorrere alla sorveglianza attiva, che va però considerata come una strategia «flessibile»: ovvero passibile di variazione sulla base degli esiti degli esami di controllo regolari(dosaggio del Psa ogni tre mesi, visita con palpazione della ghiandola a cadenza semestrale e biopsia prostatica a un anno dalla diagnosi).
«L’approccio oggi in uso è comunque differente da quello considerato nello studio e relativo agli anni ‘90 - dichiara Walter Artibani, direttore dell’unità operativa di urologia dell’azienda ospedaliero-universitaria di Verona e segretario generale della Società Italiana di Urologia -. La vigile attesa di cui si parla nello studio, non prevedeva un iter serrato di controlli, come si consiglia oggi ai pazienti a cui si consiglia la sorveglianza attiva». Al momento, si continua a discutere sui criteri che possono portare a caldeggiare questa scelta, piuttosto che l’intervento chirurgico. «Il dosaggio del Psa e la biopsia standard rischiano di non essere sufficienti a definire la scelta più appropriata - è il pensiero di Porpiglia -. Di fronte a valori sospetti, l’uso della risonanza magnetica multiparametrica e della biopsia mirata diventa indispensabile». In questo modo, come peraltro dimostrato da un’altra ricerca pubblicata nei mesi scorsi sul «New England Journal of Medicine», si ottengono diagnosi più accurate. E il ricorso alla risonanza prima della biopsia è d’aiuto nella differenziazione tra la diagnosi un tumore indolente (eventualmente gestibile con la sorveglianza attiva) e uno più aggressivo (da rimuovere in sala operatoria).
Sorveglianza attiva: per chi e quando?
A patto di essere quanto più accurati possibile al momento della diagnosi, dunque, la sorveglianza attiva non è destinata a scomparire dal ventaglio delle opportunità terapeutiche del tumore della prostata. «I numeri sono in crescita e noi continueremo a indicarla, ma la selezione dei pazienti è fondamentale: la sorveglianza o la terapia focale possono rappresentare la soluzione per chi ha un tumore poco aggressivo - prosegue Montorsi -. Le conclusioni di questo studio ci dicono che è sempre meglio operare un paziente che ha una prospettiva di vita pari almeno a dieci anni. Come tale non si intende soltanto l’adulto, ma anche un over 65 in buone condizioni. Oggi è un errore pensare che un paziente di 75 anni in salute possa evitare l’intervento, perché davanti a lui potrebbero esserci anche altri tre lustri di vita». Come limite del lavoro, occorre considerare che l’approccio al tumore della prostata è cambiato radicalmente, dalla metà degli anni ’90.
All’epoca non si conoscevano il potenziale e i limiti del Psa , la risonanza magnetica non era disponibile, al pari della chirurgia robotica , che ha ridotto l’invasività della prostatectomia. In generale, l’aspettativa di vita era più breve e la qualità della vita dopo l’intervento meno considerata. «Oggi il tumore della prostata richiede la scelta di un trattamento cucito su misura del paziente - chiosa Porpiglia -. La scelta tra la sorveglianza attiva e l’intervento non spetta al paziente, con cui va invece condivisa dal team multidisciplinare di specialisti coinvolti nella gestione di questa malattia».
Cosa sapere sulla prostata
Il ruolo della prostata è quello di fornire componenti fondamentali alla sopravvivenza e alla qualità degli spermatozoi. Motivo per cui alcune alterazioni della struttura e dello stato dell’organo possono influenzare la fertilità maschile. Il tumore non è l’unica malattia che può colpire la ghiandola: prostatiti (di origine infiammatoria) e ingrossamento della ghiandola (ipertrofia prostatica benigna) sono altre condizioni abbastanza frequenti. Filo conduttore è uno dei possibili sintomi delle tre condizioni: ovvero la difficoltà a urinare. Gli esperti consigliano una visita urologica a cadenza annuale a partire dai 50 anni, dal momento che un’adeguata prevenzione permette di scoprire (eventualmente) condizioni precoci e, come tali, più semplici da trattare.
Twitter @fabioditodaro