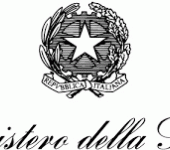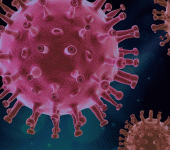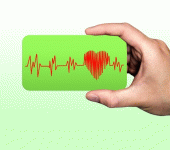Aveva deciso di andare in scena ugualmente, nonostante fosse stremato dalla tubercolosi, per «non privare del guadagno cinquanta poveri lavoratori» che vivevano del solo incasso.
La tosse che tentava di mascherare con risate forzate si faceva sempre più convulsa, ma riuscì a terminare la recita del suo capolavoro: «Il Malato immaginario».
La stessa notte di quel 17 febbraio 1673, Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière, spirava tra le braccia di due suore che lo avevano accompagnato a casa. Nella commedia interpretava il ruolo del protagonista Argante, vero monumento drammaturgico all’ipocondria. Tale malattia consiste in un disturbo di matrice essenzialmente psicologica che tuttavia, come dal precedente articolo: può produrre patologie e sofferenze fisiche reali.
Per quanto fossero ancora presenti influssi dalla commedia dell’arte, il Malato immaginario era basato su un «moderno» copione scritto e si ispirava a criteri di verità e naturalezza tanto da descrivere un tipo sociale ancora attuale.

Il protagonista è infatti un ricco borghese, di ottima salute ma convinto di essere minato da una grave malattia. Si circonda così di medici inetti come Diafoirus e Purgone - o di furbi farmacisti come Fleurant - che ne sfruttano i paranoici timori per il proprio tornaconto.
E’ contro questi medici boriosi e sciocchi che si appunta la satira del drammaturgo, ridicolizzando un principio tipico della scienza a lui coeva: il basarsi sull’«ipse dixit», ovvero su ciò che tramandavano gli antichi senza l’esperienza diretta del corpo umano e del suo funzionamento.
Al contempo, Molière descrive con straordinaria sottigliezza i sintomi e le trappole psicologiche di cui è vittima l’ipocondriaco: il vittimismo, l’ansia, il gretto egoismo, le manie di persecuzione, la saccenza medica da autodidatta, il costante sospetto (anche dei suoi medici) e la paura della morte.
Proprio per garantirsi un’assistenza sanitaria continua, Argante vuole maritare a tutti i costi la propria figlia Angelica con un ridicolo cicisbeo, figlio del dottor Diaforius. La giovane ama però il bel Cleante e grazie agli arguti stratagemmi della fantesca Antonietta, riuscirà a far trionfare il suo amore con grande scorno dei medicastri e dell’opportunista, fedifraga matrigna, interessata solo a che suo marito Argante faccia testamento in proprio favore.
Questo capolavoro teatrale ha fornito dignità di archetipo a un disturbo che è collegato con le più ataviche paure e fragilità dell’uomo che si possono rivelare anche in personaggi «al di sopra di ogni sospetto» per razionalità, intelligenza, potere o senso dell’umorismo.
Fra i grandi ipocondriaci del passato, colpisce apprendere come Charles Darwin (1809-1882), autore della teoria evoluzionista e alfiere dello scetticismo laico, si fosse dogmaticamente persuaso di essere stato contagiato, durante uno dei suoi viaggi, da una malattia tropicale. Per debellare un immaginario parassita intestinale Darwin si sottoponeva a enteroclismi di acqua gelata, prendeva bagni freddi e si avvolgeva in lenzuola umide. Proprio come l’Argante di Molière, era solito registrare le sue flatulenze per controllare il procedere del suo fantasioso malanno.

Andy Warhol (1928-1987), padre della Pop art, aveva invece un terrore assoluto degli ospedali che aumentò a dismisura nel 1968 quando, dopo essere stato ferito da una femminista in un attentato, dovette essere ricoverato. Da quel momento, la sua psiche già problematica, registrò un severo peggioramento. Come dimostrano i suoi diari, era avaro fino a livelli patologici e lesinava le spese anche sui medicinali. Preferiva, semmai, la medicina new age e la cristallo-terapia che, tuttavia, non lo salvarono da un’infezione alla cistifellea. Paradossale, ma tipico, è che molti ipocondriaci trascurino e rifuggano le cure, anche nei casi in cui si rivelano indispensabili. Quando, infatti, Warhol si decise a subire l’operazione, vincendo la paura degli ospedali, la sua situazione clinica era così compromessa che lo condusse alla morte all’età di appena 58 anni.

Caso gravissimo di ipocondria fu quello del pianista e compositore canadese Glenn Gould (1932-1982) che assumeva medicinali contro qualsiasi tipo di disagio: dolori muscolari, depressione, insonnia e così via. Naturalmente, questi farmaci producevano effetti collaterali sgradevoli e lui doveva assumerne altri, in un circolo vizioso senza fine. Si copriva all’inverosimile, con vari maglioni uno sull’altro, prendendo alla lettera le raccomandazioni della madre. Traumatica fu una pacca sulla spalla che gli diede un accordatore della Steinway: Gould reagì malissimo, tanto da citare per migliaia di dollari l’azienda. Convintosi di aver subìto una compressione alla vertebra cervicale, annullò tutti i concerti, si sottopose a ingessature immobilizzanti per mesi.
Da allora si accentuò il suo terrore per qualsiasi contatto fisico con le altre persone: temeva che lo toccassero contagiandolo con batteri o che gli stritolassero le mani. A 32 anni smise di esibirsi in pubblico, suonando, da allora, solo in studio di registrazione, al sicuro come in un utero protettivo. Morì a 50 anni per un ictus, anche debilitato dai farmaci di cui aveva abusato per tutta la vita.
Rispetto alle seriose ossessioni di Gould, Woody Allen ha invece sempre ampiamente ironizzato sulla sua ipocondria fin quasi a farne una cifra del suo humor, come nel fim Hannah e le sue sorelle. «Contrariamente a quel che crede la gente – è solito ripetere il regista - non sono un ipocondriaco, ma un genere di pazzoide completamente diverso. Sono un allarmista». E ancora: «Le due parole che uno desidera di più sentirsi dire… Ti amo? Assolutamente no. E’ benigno».
Anche per il nostro Carlo Verdone, il cinema è stato una terapia: l’attore e regista romano non ha mai fatto mistero della sua ipocondria di cui narra gustosi aneddoti, come quando, da bambino, si faceva suggestionare dal sentire la madre parlare al telefono di tumori, glaucomi e diabeti con le amiche. Da ragazzo, divorò l’Enciclopedia medica convincendosi, però, di essere vittima di una malattia degli occhi. Il panico fu tale che il giovane Verdone contrasse una congiuntivite psicosomatica.

Dopo aver consumato ansiolitici per decenni, oggi pare che si sia liberato di questo demone. Gli rimane tuttavia un’ampia cultura clinica tanto che, proprio come avviene nel finale del Malato immaginario, una troupe di attori - magari scelti fra amici e colleghi - potrebbe senz’atro conferirgli una giocosa laurea honoris causa in medicina.