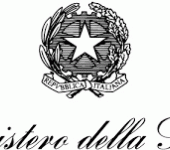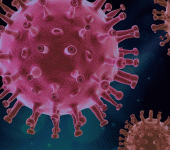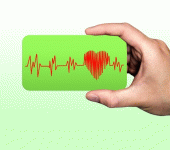La soluzione è alle porte? Non ancora. L’Alzheimer, la malattia neurodegenerativa che colpisce 50 milioni di persone nel mondo e 1,3 soltanto in Italia, resta priva di un farmaco in grado di arrestarne la progressione. Ma la comunità scientifica, nonostante diversi flop registrati nell’ultimo decennio, non ha perso le speranze di trovare una soluzione alla più invalidante tra le demenze senili. L’ultima giunge da una ricerca pubblicata su «Nature», che all’Alzheimer ha dedicato la copertina dell’ultimo numero. Al termine di uno studio di fase 1, mirato a valutare il profilo di sicurezza e tollerabilità di un farmaco, i ricercatori hanno dimostrato come l’Aducanumab si sia rivelato in grado di rimuovere i frammenti delle placche di beta amiloide, il cui accumulo è responsabile della progressione della malattia. Un risultato incoraggiante, ma che dovrà essere confermato negli studi di fase 2 e 3: già in corso su 2700 pazienti sparsi tra il Nord America, l’Europa e l’Asia. I primi risultati in tal senso sono attesi per il 2020.
Iniezioni del farmaco una volta al mese per un anno
Aducanumab s’è dimostrato in grado di sciogliere gli accumuli di beta amiloide in pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer allo stadio precoce. Nell’ultimo studio sono state arruolate 165 persone, suddivise in due gruppi: uno trattato col farmaco in fase di sperimentazione, l’altro con un placebo. L’Aducanumab è stato infuso in 103 pazienti: una volta al mese per un periodo massimo di quattordici mesi. I risultati ottenuti hanno confermato i riscontri ottenuti su modello animale. Gli effetti - oltre alla riduzione della placca, attraverso la Pet è stato osservato un rallentamento del declino cognitivo - sono risultati dipendenti dalle dosi di farmaco ricevute: uno, tre, sei o dieci milligrammi. All’aumentare di queste ultime, miglioravano anche le evidenze terapeutiche. Eric Reiman, responsabile del programma di ricerca sulla malattia di Alzheimer dell’Università dell’Arizona, ha definito la scoperta «incoraggiante, perché nessun farmaco finora testato era stato in grado di arrestare e invertire il trend di diffusione della beta amiloide». Secondo Stephen Salloway, direttore dell’unità di neurologia e del programma di ricerca sull’invecchiamento dell’Università del Rhode Island, tra gli autori dell’ultima pubblicazione, «si tratta della scoperta più interessante realizzata negli ultimi venticinque anni di studi sull’Alzheimer».
Tutta “colpa” della beta amiloide?
Vista l’esiguità del campione di pazienti trattato, i risultati vanno però considerati preliminari. A ribadirlo, nella pubblicazione, sono gli stessi ricercatori, che hanno ricordato pure come risultati simili erano emersi altre volte in passato, salvo poi naufragare nel prosieguo della sperimentazione. Le scansioni cerebrali effettuate sui pazienti trattati con Aducanumab - un anticorpo monoclonale capace di superare la barriera ematoencefalica e aggredire le placche - hanno però rafforzato l’ipotesi che l’accumulo di proteina beta amiloide sia la causa della progressiva perdita di memoria che caratterizza la malattia. Oltre alle placche, però, nei neuroni dei malati di Alzheimer di osservano anche alcuni grovigli neurofibrillari. A comporli è la proteina tau, presente anche nelle cellule nervose sane, ma che con la malattia subisce delle modificazioni anomale. La conseguenza osservata, anche in questo caso, è la morte neuronale. Ma che gli accumuli delle due proteine rappresentino l’unica causa della malattia rimane un’ipotesi ancora da dimostrare.
Twitter @fabioditodaro

Alcuni diritti riservati.