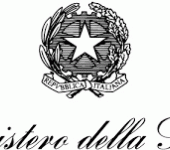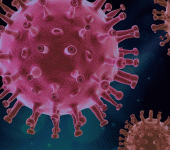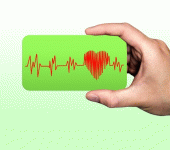Scoppiato, bruciato, esaurito sono i vocaboli che traducono al meglio il termine inglese sempre più inflazionato di burnout
Recentemente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il burnout da uno stato di esaurimento a una sindrome. Una sindrome che deriva da stress cronico sul posto di lavoro nella Classificazione Internazionale delle Malattie dell’OMS, il compendio ufficiale delle malattie. Si tratta di un passo in avanti nel riconoscimento di uno stato mentale e fisico sempre più diffuso soprattutto tra le società occidentali dove la cultura del lavoro spinge i propri impiegati verso limiti fisici e psichici per massimizzare la produttività o la performance.
Il burnout è generalmente definito come una sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e derealizzazione personale, che può manifestarsi in particolare in tutte quelle professioni con implicazioni relazionali molto accentuate.
Il burnout diventa reale, quindi e si porta dietro svariati sintomi tra cui spossatezza sul luogo di lavoro, cinismo, isolamento o in generale sentimenti negativi ed efficienza professionale ridotta.
«Il risultato è una sindrome che sfocia nello stress cronico difficile da curare con successo sul singolo» commenta Umberto Candura president dell’ANMA, Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti. L’esaurimento emotivo si caratterizza per la mancanza dell’energia necessaria per affrontare la realtà quotidiana e per la prevalenza di sentimenti di apatia e distacco emotivo nei confronti del lavoro. Il soggetto si sente svuotato, sfinito, le sue risorse emozionali sono esaurite, appunto.
Sembra una definizione così ampia che potrebbe essere applicata alla maggior parte delle persone a un certo punto della loro vita lavorativa. E infatti c’è chi ne parla come se si trattasse di una epidemia vera e propria.
Tuttavia anche se la maggior parte delle persone ha sperimentato alcuni di questi sintomi, questi sono persistenti e compromettenti solo per una minoranza, fortunatamente. Secondo alcuni esperti, non è realistico parlare di epidemia; ciò che è reale, sostengono, è uno spostamento delle attitudini culturali sul posto di lavoro. Per quanto, sia stata creata creato un’aspettativa irrealistica e fuorviante che lavoratori dovrebbero essere felici e senza stress in ogni momento, e se non lo sono, è un problema che deve essere risolto.
«Abbiamo difficoltà a definire il confine di una patologia di questo tipo sul piano medico legale. A livello sociale è invece una realtà a tutti gli effetti», spiega Candura, «abbiamo ancora difficoltà d’intervento sul piano di prevenzione, per aspetti legislativi e per aspetti di supporto sociale. Noi siamo osservatori».
Il termine burnout non è nuovo e compare per la prima volta nel mondo dello sport, negli anni Trenta, per indicare l’incapacità di un atleta, dopo alcuni successi, di ottenere ulteriori risultati e mantenere quelli acquisiti. In quel contesto il burnout è quella condizione in cui svolgere un’attività sportiva impegna ad un punto tale corpo, mente e spirito che la persona, superata una certa soglia, scoppia con conseguente stato di esaurimento psicofisico ed emozionale.
LA STORIA DEL DISTURBO: CHI NE PARLO’ PER PRIMO
Il primo ad occuparsi di burnout fu lo psicologo americano Herbert Freudenberger nel 1974, che configurò una condizione di stress lavorativo in prevalenza tra i soggetti impegnati in attività professionali di aiuto e quindi presente con maggiore frequenza nell’area socio-sanitaria e nel campo della scuola.
Il termine fu poi ripreso dalla psichiatra americana Christina Maslach, la quale ha utilizzato questo termine per definire una sindrome i cui sintomi evidenziano una patologia comportamentale a carico di tutte le professioni ad elevata implicazione relazionale e parlava di sindrome da esaurimento emotivo, da spersonalizzazione e riduzione delle capacità personali che può presentarsi in soggetti che per professione si occupano della gente.
Il burnout sarebbe una reazione alla tensione emotiva cronica del contatto continuo con esseri umani, in particolare quando essi hanno problemi o motivi di sofferenza. Christina Maslach diede un importante contributo alla ricerca grazie alla realizzazione di uno specifico strumento psicodiagnostico standardizzato, il Maslach Burnout Inventory.
«Da anni ci scontriamo con realtà lavorative pesanti, logoranti, che scatenano problemi psico-fisici. In particolare, le professioni legate all’assistenza, quindi nel mondo sanitario. La società invecchia, sempre più persone hanno bisogno di assistenza e sempre più persone assistono andando a costituire un enorme bacino di attività, in cui è diffcile mantenere la motivazione.
La perdita di motivazione crea difficoltà anche sulla qualità del lavoro con un impatto negativo. La limitazione di risorse, le persone sempre più oberate, la mancanza di risorse, la povertà di prospettive, tutti fattori che contribuiscono alla perdita di identità della figura professionale» racconta Candura.
Come è stato riportato in uno studio italiano sul Journal of Psychopathology, nell’Istituto di Psichiatitria dell’Università di Messina, alla situazione psicologica e relazionale si associano generalmente anche sintomi fisici sotto forma di vaghi malesseri, astenia, cefalea, disturbi del sonno (insonnia o ipersonnia) e algie diffuse. La sindrome del burnout rappresenta la risultante di uno squilibrio tra le richieste professionali e la capacità individuale di affrontarle; quindi una condizione che esprime una sollecitazione emozionale di frustrazione e demoralizzazione, con difese inadeguate e comportamenti maladattativi.
«Ci sono trasformazioni nel mondo del lavoro, e come medici è difficile per noi riuscire a intervenire in tempo sulla salute mentale relativa alla professione. Noi possiamo intervenire meglio sulla prevenzione del disagio lavorativo. Per noi è difficile prevedere, dovremmo lavorare in sinergia con altre figure mediche. Se una persona si trova in difficoltà e io adduco il problema al lavoro e mi attivo per sottoporre la persona in difficoltà ad una visita psichiatrica, è poi difficile fare accettare un intervento sul singolo. E’ più semplice la prevenzione sul gruppo, sulla popolazione, ad esempio creando uno sportello di ascolto nell’azienda. E in alcuni settori lavorativi, questo approccio esiste già. In sanità, ad esempio, ci sono figure particolari che seguono gli operatori per tutelarli e per non fare peggiorare la performance. Ad esempio, queste realtà si possono già trovare nelle oncologie pediatriche, dove gli operatori possono essere a rischio di burnout.
Un campo poco esplorato nella letteratura sul burnout sono i fattori protettivi. Sarebbe interessante valutare se determinate caratteristiche psicologiche positive e costruttive consentano all’operatore un maggior adattamento in contesti, come l’oncologia, dove il rischio di burnout è elevato. Da qui la possibilità di implementare programmi preventivi mirati a rafforzare certe caratteristiche positive nel professionista, come strategia da affiancare ad azioni sui fattori ambientali stressanti o sulle caratteristiche psicologiche disadattive.